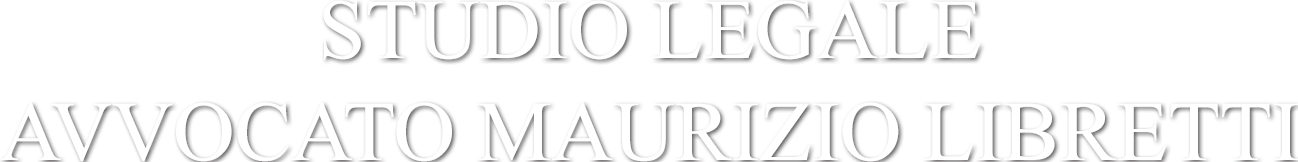Autore: avv. Maurizio Libretti
•
4 luglio 2021
Sospensione sfratti su casa principale del debitore: seconda proroga incostituzionale. Non è più proporzionato il bilanciamento tra la tutela in giudizio del creditore e quella del debitore nelle esecuzioni sull’abitazione principale (Corte cost. n. 128/2021). Illegittima costituzionalmente la seconda proroga (1° gennaio-30 giugno 2021) della sospensione delle attività nelle esecuzioni che hanno per oggetto l’abitazione principale del debitore. Lo ha stabilito il collegio della Corte Costituzionale nella sentenza n. 128 depositata il 22 giugno 2021. Il decreto Cura Italia aveva previsto la sospensione dell'esecuzione degli sfratti fino al 31 agosto 2020, il decreto Rilancio a causa del protrarsi della crisi per famiglie e aziende aveva ulteriormente spostato la sospensione degli sfratti fino al 31 dicembre 2020. Ma questa proroga per la Consulta non risulta più proporzionato il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del creditore e quella del debitore nelle procedure esecutive relative all’abitazione principale di quest’ultimo, in considerazione della circostanza che i giudizi civili (che comprendono quelli esecutivi), a seguito dell’iniziale sospensione generalizzata, sono ripresi gradualmente con modalità compatibili con l’emergenza sanitaria. Mentre, al contrario, la sospensione prevista dalla disposizione finita sotto la lente del collegio è rimasta immutata nei medesimi presupposti, ed è stata ulteriormente prorogata, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per un ulteriore semestre. Nel ribadire che il diritto all’abitazione ha natura di «diritto sociale», il collegio romano ha evidenziato che il sacrificio richiesto ai creditori avrebbe dovuto essere dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori, con l’indicazione di adeguati criteri selettivi. Nella seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale, all'opposto, non è stato individuato alcun criterio selettivo preordinato a giustificare l’ulteriore protrarsi della paralisi dell’azione esecutiva. RIMANE INVECE IN VIGORE LA SOSPENSIONE PER TUTTE LE CONVALIDE DI SFRATTO DICHIARATE DOPO IL 28 FEBBRAIO 2020 IN PIENO PERIODO COVID 19. Il decreto sostegni prevede una ulteriore proroga per gli sfratti che sarebbero dovuti scadere il 30 giugno 2021 (ora dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale). Un emendamento approvato all’ultima ora prevede una doppia proroga differenziata a secondo della data del provvedimento di rilascio: - per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio e il 30 settembre 2020 il blocco si avrà fino al 30 settembre 2021 - per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021 il blocco si avrà fino al 31 dicembre 2021 . Gli sfratti convalidati dopo il 30 giugno 2021 non avranno limiti di sospensione dell'esecuzione.

Autore: avv. Maurizio Libretti
•
13 giugno 2021
Cosa succede al conto corrente se viene pignorato quando c'è un affidamento e cosa succede se dopo il pignoramento vi sono degli accrediti (poste attive) versate sullo stesso conto ? Cerchiamo di fare il punto. La dichiarazione del terzo in caso di pignoramento di conto corrente Una volta ricevuta la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, avente ad oggetto le somme detenute dal debitore esecutato su un conto corrente, la Banca terza pignorata deve rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. In particolare, il terzo pignorato (Banca) deve dichiarare al creditore e al giudice solo gli importi di cui è debitore dell’esecutato al momento in cui effettua la dichiarazione e gli eventuali successivi accrediti (poste attive), ma solo laddove questi non vadano ad estinguere poste passive maturate successivamente alla dichiarazione di quantità ed antecedentemente all’accredito (posta attiva). L’art. 546 c.p.c. statuisce che, dal giorno in cui è notificato l’atto previsto nell’art. 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode, con riferimento alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà. Stando al tenore letterale della disposizione in parola, letto in congiunzione con l’art. 547 c.p.c., l’obbligo di custodia scatta per il terzo qualora, nel momento in cui viene da lui eseguita la dichiarazione o, secondo altro orientamento, nel giorno in cui riceve la notifica dell’atto di cui all’art. 543 c.p.c., sussista un debito nei confronti del debitore esecutato (cfr. Cass. Civile, n. 15615/2005 e Cass. Civile, n. 12602/2007). Pertanto, nel rendere la dichiarazione di terzo, la banca deve limitarsi a verificare se, alla data della notificazione del pignoramento ed anche successivamente, il conto corrente intestato al debitore esecutato presenti o meno un saldo positivo. In caso di saldo positivo, il terzo dovrà dichiarare l’ammontare delle somme presenti sul conto; laddove il saldo del conto corrente fosse negativo (e rimanesse sempre negativo), la banca deve dichiarare di non essere debitor debitoris. L’impignorabilità del margine disponibile Fatta questa premessa, è necessario chiarire alcuni aspetti in punto di pignoramento di conto corrente affidato. La giurisprudenza, infatti, si è chiesta se potesse essere oggetto di pignoramento un conto corrente affidato, con un saldo negativo al momento della notifica del pignoramento, ma integrato da successivi versamenti. Il conto corrente affidato con saldo negativo è impignorabile, in quanto il c.d. “margine disponibile” – i.e. “la quota di disponibilità utilizzabile in presenza del fido concesso” (cfr. Trib. Roma, n. 20024/2011) – non può essere oggetto di pignoramento presso terzi. L’affidamento bancario è una somma messa a disposizione della banca, che può essere prelevata (entro i limiti pattuiti con l’istituto bancario) dal correntista anche qualora il saldo del proprio corrente sia negativo. Pertanto, il fido, vale a dire la somma “messa a disposizione del correntista” dalla banca, non può essere vincolato. La ratio di tale principio è da rinvenirsi nel fatto che il fido bancario riguarda somme di denaro non già di proprietà del correntista, bensì della Banca (cfr. Corte d’Appello di L’Aquila, n. 1385/2019). In caso di conto corrente affidato con saldo negativo, la Banca non può che rendere una dichiarazione ex art. 547 c.p.c. negativa, non risultando il correntista creditore di alcuna somma nei confronti dell’istituto bancario. Pertanto, anche laddove dovessero affluire sul conto corrente affidato delle rimesse, le stesse non potranno essere pignorate, se le poste attive hanno solo ridotto lo scoperto bancario, ma non hanno portato il conto corrente ad un saldo positivo. Ed infatti, i successivi versamenti affluiti sul conto corrente hanno solo carattere ripristinatorio della provvista, essendo meramente finalizzati a ridurre o ad estinguere il saldo debitore. Come statuito da costante giurisprudenza, le singole rimesse non possono essere pignorate, dando luogo il conto corrente ad un “rapporto giuridico unitario” (Cass. Civile, n. 6393/2015), con la conseguenza che il creditore procedente non può pignorare i singoli versamenti e beneficiare delle sole poste attive del debitore, trascurando quelle negative. Il pignoramento, dunque, può riguardare il solo eventuale saldo positivo del conto corrente. Pertanto, i singoli versamenti del correntista accrescono, in caso di saldo positivo, il debito della banca, e, in caso invece di saldo negativo, riducono od estinguono il credito della stessa banca (cfr. Corte d’Appello di Napoli, sez. IV bis, 23 febbraio 2012). Nel momento in cui deve rendere la dichiarazione, il terzo pignorato deve limitarsi a verificare se, alla data della notificazione del pignoramento ed anche successivamente, il conto corrente affidato presenti o meno un saldo positivo. Se il saldo è sempre rimasto negativo, la Banca correttamente dichiara di non essere debitrice dell’esecutato. Corretta è, quindi, la dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c. del terzo pignorato, laddove il saldo del conto corrente sia negativo, anche qualora siano stati effettuati successivi versamenti sul conto corrente, che hanno semplicemente ridotto il saldo debitore, ma mai trasformato lo stesso in saldo creditore. La giurisprudenza ha affermato sul punto che l’affidamento bancario fa sorgere un obbligo restitutorio a carico del cliente, di importo pari alle somme prelevate; la banca “non può essere, in alcun modo, considerata debitor debitoris per le somme oggetto del fido” (cfr. Trib. Roma, n. 20024/2011). I successivi prelievi del debitore esecutato in caso di conto corrente affidato. A seguito della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, il debitore esecutato, in caso di conto corrente affidato con saldo negativo, può effettuare prelevamenti e pagamenti nei limiti della somma concessa in affidamento. Ed infatti, se nel momento in cui rende la dichiarazione del terzo, la Banca afferma di non aver alcun debito nei confronti del debitore esecutato, sulla stessa non incombe alcun obbligo di custodia, vale a dire alcun obbligo di blocco della somma giacente sul conto corrente e, quindi, di impedimento di prelievi di somme da parte della correntista. La Banca non ha, quindi, l’onere di evitare che l’esecutato aggravi la propria esposizione debitoria. La ratio di tale principio è riconducibile al fatto che l’imposizione al terzo di compiere condotte finalizzate a favorire esclusivamente il creditore procedente violerebbe il principio dell’autonomina privata, secondo il quale ciascun consociato deve disporre liberamente del proprio patrimonio. Ciò posto, non potrebbe pretendersi dal terzo pignorato – creditore dell’esecutato e non già debitor debitoris – di sacrificare il proprio legittimo interesse alla conservazione dell’esposizione debitoria dell’esecutato, a vantaggio della mera aspettativa di un altro creditore (cfr. Trib. Arezzo, n. 23/2020). La Banca, dunque, non ha alcun obbligo di bloccare l’operatività del conto corrente affidato e, conseguentemente, in caso di successivi prelievi posti in essere dal debitore esecutato, non avrà violato alcun obbligo di custodia. Come detto, in casi di prelievi delle somme messe a disposizione, è la Banca a diventare creditrice delle somme prelevate dal correntista.
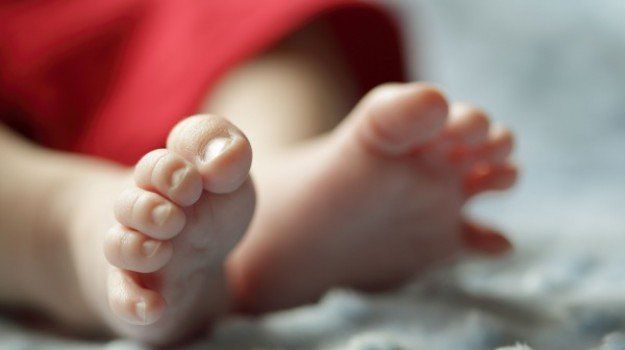
Autore: avv. Maurizio Libretti
•
27 febbraio 2021
L’accesso all’assegno unico è assicurato per ogni figlio a carico con i criteri di universalità e progressività di seguito elencati: l’ammontare dell’assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall’Isee o da sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo all’offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare; ai fini dell’accesso e per il calcolo di altre prestazioni sociali agevolate, il computo dell’assegno unico e universale può essere differenziato nell’ambito dell’Isee fino eventualmente ad azzerarsi; è pienamente compatibile con la fruizione del Reddito di cittadinanza; non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità; è ripartito nella misura del 50% tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale; è concesso in forma di credito d’imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro. Decorrenza Il beneficio decorre a partire dal 7° mese di gravidanza. Spetta siano a 21 anni Dai 18 ai 21 anni, sempre per i figli a carico, l’assegno è corrisposto con importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, ma solo in presenza di determinate condizioni (es. percorsi di formazione scolastica, tirocini o percorsi lavorativi a basso reddito, disoccupazione) con la possibilità, peraltro, di corrisponderlo direttamente al figlio maggiorenne, per favorirne l’autonomia. Figli disabili Per quanto riguarda i figli con disabilità, è prevista una maggiorazione graduata secondo la gravità della disabilità rispetto agli importi riconosciuti ai figli minorenni e maggiorenni in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50%. In tal caso l’assegno viene corrisposto, senza maggiorazione, anche dopo il compimento del 21° anno di età qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico. Terzo figlio Per i figli successivi al secondo, l’importo dell’assegno è maggiorato. Condizioni L’assegno universale è subordinato al possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: - essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero essere un cittadino di paesi facenti parte dell’Ue, o suo familiare, in quanto titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere un cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale; - essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; vivere con i figli a carico in Italia; - essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

Il certificato medico attestante il contagio da Covid 19 è sufficiente per riconoscere l'infortunio.
Autore: avv. Maurizio Libretti
•
9 maggio 2020
L'esame della Circolare n. 13 del 2020 ha evidenziato alcuni aspetti di consistente differenza tra l'infezione da Covid-19 rispetto ad altre malattie infettive o infortuni contratte sui luoghi di lavoro. L’infezione da Covid 19 ha caratteristiche peculiari che la distinguono dalle altre infezioni. Uno dei temi principali riguarda l'impossibilità, in ragione della pandemica diffusione del virsu, di stabilire con certezza se la malattia sia stata contratta nell’ambiente lavorativo oppure più semplicemente in un ambiente sociale e/o famigliare. La difficoltà per altro è maggiore laddove, come nel bresciano o nel bergamasco, la dimensione della diffusione del contagio non è stata ancora appieno compresa, a causa dell’esiguità dei test sinora svolti in rapporto alla popolazione. L'Inail si è posta il problema e ha cercato di risolvere alcune questioni con la sopra citata circolare. E' evidente che uan interpretazione eccessivamente rigorosa di rischio porterebbe ad escludere nella stragrande maggioranza dei casi il riconoscimento della tutela, ed al contrario una interpretazione estesa del rischio avrebbe come conseguenza riconoscere indistintamente a tutti le provvidenze con insostenibilità del sistema. Per l’individuazione del rischio assicurato l’Inail ha adottato i criteri della ragionevolezza, connesso al principio di presunzione semplice, ed il criterio logico -scientifico, connesso ad un principio di presunzione qualificata. In particolare l’Inail ha distinto due fondamentali categorie di lavoratori. Nella prima si collocano i lavoratori esposti ad elevato rischio sanitario, quali, in primis, gli operatori sanitari e poi tutti i lavoratori che si trovino a contatto col pubblico o all'utenza (quali ad esempio i lavoratori di front office, cassieri, banconisti, addetti alle pulizie in strutture sanitarie ed altri similari). Nella seconda categoria rientrano tutti gli altri lavoratori. Per espressa previsione della Circolare la prima categoria non è chiusa ed in essa rientrano quindi tutti i soggetti che (previo accertamento in concreto) si trovino a contatto o con il virus (ad esempio lavoratori addetti alle pulizie ma anche alle pompe funebri) o con l’utenza (ad.es. i riders). Per la prima categoria il rischio professionale viene individuato mediante l’applicazione del principio di presunzione semplice di origine professionale, stante l’elevato rischio di contagio insito nella mansione espletata, mentre per la seconda categoria di lavoratori, allorché non sia possibile risalire all’episodio che ha determinato il contagio e non si possa presumere la correlazione tra attività prestata e contagio, vale invece il criterio scientifico medico-legale, generalmente accolto, che privilegia i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale. Distinguere le due categorie di lavoratori comporta diverse modi di provare (onere probatorio) nei confornti dell'Inail l'avvenuta infezione sui posti di lavoro e quindi la possibilità di far valere il suo diritto. Nel caso di lavoro appartenente alla prima categoria , il lavoratore dovrà SOLO provare di essere stato contagiato e di essere adibito ad una di quelle lavorazioni e rientrino nella categoria oppure ad attività equiparabili a quelle della prima categoria. In questi casi sarà l’Inail a dover fornire la prova (diabolica per l'Ente) che il contagio sia avvenuto fuori il contesto lavorativo. Vi è in sostanza l'inversione dell'onere della prova. Nel caso di lavoro appartenente alla seconda categoria, invece, l’onere di provare e dedurri fatti a suo favore è a carico del lavoratore. Quindi è più gravoso perché, anche se non ha particolare rilevanza quando il contagio sia avvenuto deve però provare i fatti e le circostanze dai quali si possa presumere che il virus è contratto nell’ambiente di lavoro ed in occasione di questo. Sarà il consulente medico che dovrà poi valutare –affidandosi ai criteri epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale- se tali fatti, allegati e provati, consentano di ritenere probabile che il contagio sia avvenuto durante il lavoro o durante il tragitto casa - lavoro. Per i lavoratori rientranti nella seconda categoria, quindi, l’onere della prova è interamente a carico dell’istante mentre all’Inail compete o la controprova dei fatti allegati dalla controparte oppure la prova dell’interruzione del nesso causale tra il lavoro e l’evento. Il lavoratore ha in carico una responsabilità maggiore perché richia di perdere il riconoscimento dell'infortunio/malattia professionale nell'ipotesi in cui egli per sua colpa non faccia uso di dispositivi di protezione individuale o non osservi le distanze di sicurezza o comunque non osservi le misure di precauzione imposte con DPCM o dalle ordinanze regionali. La circolare Inail 13/2020, inoltre, dedica un paragrafo in cui stabilisce il riconoscimento dell'infortunio le ipotesi in cui il contagio sia avvenuto nel tragitto casa/lavoro (infortunio in itinere), stabilendo anche che utilizzare il mezzo proprio anziché il mezzo pubblico in questo contesto sia più sicuro per il lavoratore sicché, per tutta la durata del periodo di emergenza sanitaria, prevede una deroga all’art.13 D.lvo 38/2000 considerando preferibile utilizzare mezzi propri nello spostamento casa/ lavoro. Altra novità significativa sono gli effetti della attestazione con certificato medico di contratta infezione. Così la circolare: " … Il primo periodo del comma 2, del citato articolo 42 ribadisce che, nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica (prevista dall’articolo 53, commi 8, 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) all’Inail, che prende in carico e assicura la relativa tutela all’infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio. ... ... Si rappresenta l’importanza di acquisire la certificazione dell’avvenuto contagio, in quanto solo al ricorrere di tale elemento , assieme all’altro requisito dell’occasione di lavoro, si perfeziona la fattispecie della malattia-infortunio e, quindi, con il conseguente obbligo dell’invio del certificato di infortunio è possibile operare la tutela Inail. Ai fini della certificazione dell’avvenuto contagio si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso. Resta fermo, inoltre l’obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere telematicamente all’Istituto il certificato medico di infortunio. In proposito, si segnala l’opportunità di valutare in favore dell’infortunato alla luce della situazione emergenziale, sia la redazione della predetta certificazione, sia le modalità di trasmissione, avendo cura principalmente di accertarne la provenienza. … " In sostanza la Circolare ha imposto all’Inail la necessità di acquisire il certificato medico nonché la conferma clinica-strumentale attestante il contagio. L’art.53 T.U. impone la produzione del certificato in uno con la denuncia di infortunio, ma non configura il certificato come elemento costitutivo del diritto, atteso che elemento costitutivo del diritto è la malattia o la lesione all’integrità psicofisica, ma non il certificato che l’attesta. Posto che il certificato medico e la documentazione strumentale allegata assumono valenza di elemento costitutivo del diritto assicurato, la Circolare prevede che, in caso di documentazione insufficiente, l’Istituto debba farsi parte diligente ed “acquisire tempestivamente la documentazione attestante la conferma diagnostica del contagio. Ne consegue che l’obbligo di produzione incombe sul datore di lavoro , ma l’Inail deve farsi parte attiva e diligente posto che “ detta documentazione clinico –strumentale è indispensabile per la verifica della regolarità sanitaria ed amministrativa… del caso ”. La previsione del certificato medico come elemento costitutivo e di un obbligo di istruttoria rafforzata a carico dell’Ente sono indubbiamente due elementi di novità introdotti dalla Circolare, giustificati dalla peculiarità della trattazione del caso di infezione da Coronavirus. La diagnosi clinica strumentale attesta con certezza che il virus sia stato effettivamente contratto e quindi attesta l’esistenza nell’infortunio sul lavoro, posto che la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta, perché l’azione lesiva insita nella virulenza dell’agente costituisce ex sé causa violenta. Al contempo il certificato medico e gli accertamenti diagnostici e strumentali permettono, soprattutto per le lavorazioni comprese nella seconda categoria, di esprimere un giudizio medico-legale in base ai criteri epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale. Diversamente, in mancanza di certificato medico e di documentazione diagnostica e strumentale, la prova del contagio nell’ ambiente di lavoro e la controprova del contagio nell’ambiente sociale/familiare sarebbe estremamente complessa e di esito incerto, visto il contesto pandemico ed universale di diffusione del Virus.
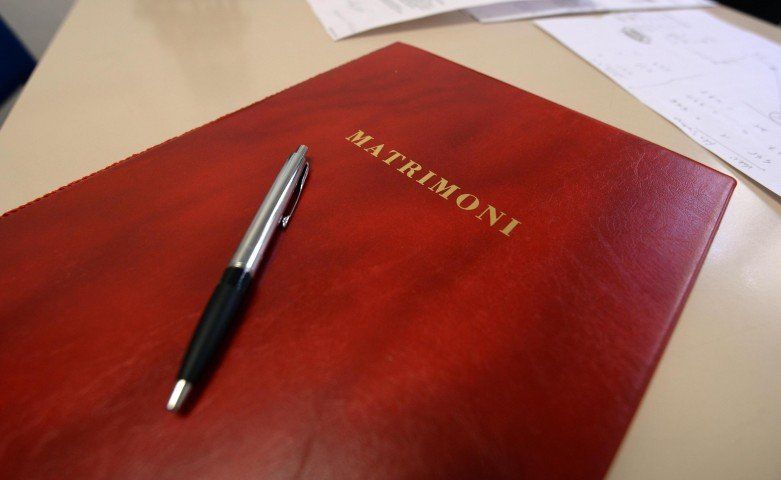
Autore: avv. Maurizio Libretti
•
29 aprile 2020
Attraverso un caso particolare cassando una sentenza di Corte di Appello, la Corte di Cassazione ha ricordato un principio riguardante la distinzione tra assegno di divorzio e assegno di separazione. E' stato precisato la diversa natura dell’assegno di divorzio rispetto a quello di separazione, per poi soffermarsi sui presupposti dell’assegno divorzile e sull’incidenza del criterio del tenore di vita. La separazione – e di conseguenza anche il relativo assegno – presuppone la permanenza del vincolo coniugale. Si tratta solo di una sospensione dei doveri “personali” del matrimonio (quali quello di convivenza, di fedeltà e di collaborazione), mentre rimangono i doveri di natura economica. Con il divorzio, alc contrario, vengono medno tutti i rapporti tra i coniugi, personali ed economici. Anche il giudizio tra separazione e divorzio è del tutto autonomo e i criteri che valgono per la determinazione dell'assegno di separazione sono diversi da quello del divorzio. Si parla, infatti, di completa autonomia dei due procedimenti. Deriva da questo la diversa natura assolta dai due correlati assegni . Quello di separazione mira in buona sostanza a mantenere, in favore del coniuge più debole economicamente, lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio; l’assegno di divorzio , invece, ha solo lo scopo di garantire all’ ex coniuge, più debole economicamente, il necessario per vivere ed essere autosufficiente : non deve essere calcolato, dunque, in base al precedente tenore di vita della coppia. Più precisamente, l'assegno divorzile in favore dell' ex coniuge ha natura assistenziale , ma anche perequativo-compensativa , discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che permette la determinazione di un contributo volto, non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, della inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive e fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e dell’apporto fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole, alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Il provvedimento, infatti, esplicita chiaramente come «Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità per la piena definizione operatane dalle Sezioni Unite di questa Corte, non entra più a comporre la cornice dell’assegno divorzile il mantenimento del pregresso tenore di vita», sottolineando come quest’ultimo abbia rilievo «in caso di assegno di mantenimento da fissarsi in sede di separazione», mentre – prosegue il Supremo Collegio – «nella determinazione dell’assegno ex art. 5 l l. 898/1970 debba restare estranea ogni esigenza di mantenimento del pregresso tenore di vita». In conclusione la Corte di Cassazione ha ritenuto, “in accoglimento dei motivi introdotti” di cassare la sentenza impugnata della Corte d’Appello di Milano, rinviando alla stessa Corte in composizione diversa per permetterne una rilettura, alla luce del nuovo orientamento affermatosi, dal quale ciascuno trae le proprie conclusioni.

Autore: avv. Maurizio Libretti
•
19 aprile 2020
Come noto allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con successivi provvedimenti del Presidente del Consiglio (gli ormai purtroppo ben noti “DPCM”) è stato imposto a tutte le persone fisiche il divieto di spostamento, salvo che motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o di salute, dapprima in entrata e uscita e all’interno della Regione Lombardia e di altre 14 province c.d. “rosse” (DPCM 08.03.2020), e successivamente in tutta Italia (DPCM 09.03.2020). Con successivo DPCM 22.03.2020 è stato poi sancito il “divieto di trasferimento o spostamento ad altro Comune, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute”. Non è infrequente, in questi giorni, ricevere richieste di genitori separati in cerca di informazioni su come comportarsi nelle visite con i figli. In molti si sono già chiesti che cosa succeda alle famiglie in cui papà e mamma vivono in case diverse e magari in Comuni diversi: possono i genitori spostarsi per recarsi a prendere i figli o riportarli dall’altro genitore? Consultando le FAQ pubblicate sul sito del Governo, si legge che “Gli spostamenti per raggiungere figli minorenni presso l’altro genitore o per condurli presso di sé sono consentiti in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o di divorzio”. Ma che ne è dei genitori che vivono in case diverse e i cui accordi relativi alle modalità di visita ai figli non sono state disciplinate da alcun provvedimento del giudice? E che succede se il genitore che si è allontanato dalla casa familiare, temendo di non riuscire a vedere i figli, decida di ritornarvi? Papà e mamma stanno affrontando con fatica e sofferenza il percorso verso il raggiungimento di accordi volti alla ri-organizzazione della famiglia, guidati dalla comune intenzione di trovare un nuovo assetto familiare che consenta ai loro bambini di mantenere una stabile e valida relazione con entrambi i genitori. Per facilitare il dialogo ed evitare momenti di tensione e liti davanti ai bimbi, papà ha trovato un appartamento in affitto in un Comune limitrofo rispetto alla casa familiare, l’ha reso confortevole e adatto ad accogliere i figli e, d’accordo con la mamma, vi si è trasferito da circa sei mesi. I genitori si sono accordati provvisoriamente in modo tale che i bambini possano già trascorrere del tempo con il padre, presso il quale soggiornano dal venerdì alla domenica a weekend alternati e il mercoledì sera fino alla mattina successiva quando il papà li accompagna a scuola. L’accordo in tal modo assunto, tuttavia, non è stato formalizzato in alcun modo e, tantomeno è oggetto di un provvedimento del giudice. I genitori del caso ipotizzato, così come tutti i genitori che in questo momento stanno vivendo situazioni analoghe, si devono confrontare con le norme restrittive emanate dal Governo al fine di contenimento e contrasto della diffusione del virus Covid-19. I provvedimenti che si sono susseguiti in questo mese di marzo non hanno stabilito espressamente nulla con riferimento agli spostamenti finalizzati a consentire ai minori di trascorrere il tempo con papà e mamma che vivano in case diverse. Il DPCM 08.03.2020 ha stabilito per tutte le persone fisiche il divieto di spostamento, salvo che motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o di salute in entrata e uscita e all’interno della Regione Lombardia e di altre 14 province c.d. “rosse”, divieto esteso con successivo DPCM 09.03.2020 a tutta Italia, ferma in ogni caso la facoltà di rientro alla propria residenza o domicilio. Con ulteriore limitazione alla libertà di movimento delle persone, il successivo DPCM 22.03.2020 ha sancito il “divieto di trasferimento o spostamento ad altro Comune, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute”, mantenendo, per gli spostamenti all’interno del territorio del Comune la precedente disciplina, ed escludendo esplicitamente la facoltà di rientro al domicilio o residenza. Se, dunque, per muoversi all’interno del Comune è sufficiente addurre la sussistenza di una “situazione di necessità”, per uscire ed entrare da ogni Comune è richiesto che ricorra una “esigenza di speciale urgenza” ed in ogni caso non è ammesso il rientro alla propria residenza o domicilio se non motivato dalle specifiche ragioni di cui sopra. Con provvedimento reso immediatamente dopo l’entrata in vigore del DPCM 9.3.2020, a seguito di ricorso d’urgenza di una madre che chiedeva il rientro immediato dei figli presso di sé ed una limitazione del diritto di visita dell’altro genitore in conseguenza della restrizione di movimento imposta dal Governo, il Tribunale di Milano ha rilevato come il Decreto “♯Iorestoacasa”, non vietando il rientro al domicilio o residenza, non potesse dirsi preclusivo delle disposizioni di affido e collocamento del minore, sottolineando altresì come il governo nella proprie FAQ avesse chiarito che “gli spostamenti per raggiungere figli minorenni presso l’altro genitore o per condurli presso di sé sono consentiti in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o di divorzio” (Trib Milano, 11.3.2020). L’esplicita soppressione, per effetto del successivo DPCM 22.03.2020, della previsione secondo la quale è in ogni caso consentito il rientro presso il domicilio o residenza, in combinato con l’introduzione di un preciso divieto di spostamento (art. 1, lett. b, DPCM 22.03.2020: “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi…”), in luogo dell’indicazione ad “evitare ogni spostamento” (art. 1, lett. a, DPCM 08.03.2020), rende lecito il domandarsi se dal dictum del Tribunale di Milano possano essere tratte indicazioni utili anche a seguito del mutamento della disciplina dell’emergenza. Non solo, infatti, è venuto espressamente a mancare il richiamo normativo alla possibilità di rientro al domicilio o residenza, ma – per quanto riguarda gli spostamenti al di fuori del Comune – è venuta meno anche la possibilità di motivare il proprio spostamento adducendo l’esistenza di ragioni di necessità – tra le quali certamente anche quella di visitare o portare presso di sé i figli -, sostituita dalla ben più stringente indicazione della “speciale urgenza”. Vero è che l’art. 51 c.p. prevede che “l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità”: ed infatti il Governo, nelle FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale, ha precisato espressamente che gli spostamenti effettuati dai genitori in conformità dei provvedimenti assunti dal giudice della separazione o del divorzio sono in ogni caso ammessi, e dunque non punibili. E ciò, dunque, ragionevolmente, quand’anche portino il genitore non collocatario a spostarsi al di fuori del Comune dove egli si trovi. E ciò, anche quando le modalità di permanenza dei minori presso ciascuno dei genitori non siano contenute in una sentenza che pronunci la separazione o il divorzio o nel decreto che omologhi gli accordi tra i coniugi, ma in un accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita, stante che il comma 3° dell’art. 6 del D.L. 132/2014, convertito in Legge 162/2014, prevede che l’accordo raggiunto a seguito della convenzione “produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”. Non così chiara, al contrario, la situazione di quei genitori che abbiano solo provvisoriamente pattuito le modalità di visita ai figli, magari senza alcuna formalizzazione delle stesse, o che si siano anche solo temporaneamente allontanati per un momento di riflessione. L’esigenza di mantenere un rapporto costante con entrambi i genitori sembra certamente integrare quella situazione di necessità per i minori che rende lecito lo spostamento dei medesimi e dei genitori stessi all’interno del Comune, e probabilmente anche quei “motivi di salute” che consentono lo spostamento anche al di fuori del Comune di residenza. Come è stato già puntualmente rilevato, è certo che il diritto del minore ad una valida e costante presenza di entrambi i genitori è principio che deve informare di sé ogni provvedimento legislativo e, dunque, l’interpretazione dello stesso. Il diritto alla bigenitorialità è posto infatti non solo dagli artt. 315bis e 337ter c.c., ma anche dall’art. 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo, la quale Convenzione all’art. 3 pone in generale il principio del best interest of child quale principio informatore di ogni decisione relativa al minore. L’art. 8 della CEDU prevede che “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare”, tanto che non può esservi in essa alcuna ingerenza, salvo che tale ingerenza “sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. Nella valutazione della possibilità per i genitori che vivano separati di spostarsi per andare a trovare o prendere i propri figli per portarli presso di sé, senza incorrere in sanzioni, dovranno dunque essere bilanciati, da un lato, l’imprescindibile diritto del minore a poter contare su una continuativa relazione anche in presenza con entrambi i genitori e, dall’altro, la necessità di salvaguardare l’integrità fisica del minore stesso, non esponendolo a maggiori rischi di contagio collegati allo spostamento, nonché la necessità di salvaguardare la salute pubblica, limitando al massimo gli spostamenti non necessari. La valutazione delle ragioni di necessità, così come quelle di speciale urgenza, nonché dei motivi di salute, è alla base dell’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1 D.L. 25.03.2020 n. 19 che, innovando la precedente disciplina, ha escluso l’applicabilità dell’art. 650 c.p., prevedendo, per il caso di violazione del divieto di spostamento delle persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie da 400 a 3.000 euro, aumentabili fino ad un terzo nel caso in cui la violazione sia avvenuta mediante l’utilizzo di un veicolo. Particolarmente importante sarà dunque poter attestare, “comprovare”, la sussistenza delle ragioni che possano sostenere la necessità o l’urgenza dello spostamento, il fatto cioè che quello spostamento nel corso del quale il genitore è fermato dagli agenti di polizia è motivato con la necessità di andare a prendere il figlio non convivente: in assenza di un provvedimento che attesti il diritto del genitore a tenere con sé il figlio il mercoledì sera, ad esempio, non potrebbe infatti essere facilmente verificato che il genitore si stia spostando proprio al fine di ottemperare a quanto previsto. Il genitore dovrà dunque essere in condizione di attestare l’esistenza di una situazione di separazione, la presenza di figli minori, nonché la residenza o il domicilio dei genitori in due diverse abitazioni, oltre che l’esistenza di accordi che regolano il diritto di visita del genitore non collocatario. Molte possono essere, tuttavia, le situazioni in cui i genitori non siano in condizione di produrre un provvedimento di separazione o di divorzio dal quale risultino le modalità di permanenza dei minori presso ciascuno dei genitori. Pensiamo al caso di un procedimento per separazione giudiziale per il quale non vi sia ancora stata l’udienza presidenziale, e dunque non vi sia alcun provvedimento provvisorio, o ad accordi contenuti in un ricorso per separazione consensuale depositato e in attesa di fissazione di udienza. Entrambe situazioni sulle quali incide la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile delle udienze e dei termini processuali di cui all’art. 83, comma 3, lett. a) D.L. 17.03.20202 n. 18. Si pensi anche all’ipotesi in cui i genitori abbiano sottoscritto il ricorso contenente gli accordi di separazione, ma tale ricorso non sia ancora stato depositato; o all’ipotesi in cui sia stato sottoscritto l’accordo di negoziazione assistita senza che lo stesso sia stato trasmesso al procuratore della Repubblica (trasmissione che, peraltro, dovrebbe avvenire ad opera degli avvocati entro 10 giorni dalla sottoscrizione, termine che potrebbe ipotizzarsi essere altrettanto sospeso in virtù del medesimo art. 83 D.L. 18/2020). Entrambe fattispecie nelle quali i genitori potranno disporre di, e mostrare nel momento dell’eventuale controllo, un accordo sottoscritto dagli stessi e controfirmato dagli avvocati che li assistano nella procedura. Così come potranno mostrare un accordo, anche provvisorio, i genitori che siano assistiti da avvocati nell’ambito di una procedura collaborativa, allegando anche il contratto di partecipazione sottoscritto in fase di adesione alla procedura. Ma si può pensare anche a genitori che stiano seguendo un percorso di mediazione familiare e che magari stiano già attuando modalità di visita ai figli concordate durante gli incontri di mediazione: in tal caso, i genitori non disporranno di alcun documento se non il contratto di partecipazione alla mediazione familiare, oltre che l’eventuale accordo informale scambiato tra gli stessi e senza alcuna sottoscrizione da parte del mediatore. Queste alcune delle ipotesi e dei comportamenti che potrebbero essere utili al fine di comprovare le ragioni dello spostamento: ma se il genitore che si è allontanato dalla casa familiare decidesse di farvi ritorno per non rischiare di non poter vedere i figli fino al termine del lockdown? In altri termini: quando il genitore che lascia la casa familiare ha diritto a ritornarci? Esiste un diritto dei coniugi alla coabitazione, oltre un dovere in tal senso? Se è chiaro, infatti, che il provvedimento che abbia assegnato ad uno dei genitori la casa familiare (o l’accordo omologato, ovvero contenuto in un accordo di negoziazione assistita autorizzato dal PM) dovrà essere rispettato ed è dunque da escludere che il genitore non assegnatario possa imporre il proprio ritorno nella casa familiare, occorre soffermarsi sull’eventuale efficacia vincolante degli accordi non omologati ma semplicemente sottoscritti dai coniugi. L’accordo tra i genitori circa la permanenza dei minori presso ciascuno ha certamente un contenuto non completamente disponibile per le parti, considerando che ai sensi dell’art. 158 c.c. il giudice può rifiutare l’omologazione – previa riconvocazione dei coniugi – quando ritenga che gli accordi siano contrari agli interessi dei minori; analogamente, ai sensi dell’art. 6, comma 3°, D.L. 132/2014 (convertito con modifiche in L. 162/2014), in presenza di figli minori, l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere trasmesso al procuratore della Repubblica, il quale lo autorizza se ritenuto corrispondente agli interessi dei minori. La Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla validità di pattuizioni precedenti al decreto di omologa e non trasfuse negli accordi poi omologati, ha specificato che le stesse possono ritenersi efficaci unicamente se riguardino un aspetto non regolato dall’accordo poi omologato e certamente compatibile con esso, ovvero siano meramente specificative, ovvero ancora si pongano rispetto agli accordi omologati “in posizione di conclamata e incontestabile maggiore o uguale rispondenza all'interesse tutelato attraverso il controllo di cui all'art. 158 cod. civ” (C. 20290/2018; nello stesso senso da ultimo, T. Livorno 7.2.2018). Con sentenza 24621/2015 la Suprema Corte di cassazione, rilevato come il legislatore abbia negli ultimi anni attribuito ampia rilevanza all’autonomia negoziale tra i coniugi, e come all’interno degli accordi di separazione debbano essere tenuti distinti contenuti necessari (affidamento figli minori, assegnazione casa coniugale, mantenimento dei figli e del coniuge debole) accanto a contenuti solo eventuali (definizione di altri rapporti patrimoniale o personali tra i coniugi), ha riconosciuto all’accordo avente oggetto diritti patrimoniali dei coniugi effetti direttamente vincolanti tra gli stessi senza necessità di sottoporre l’accordo al giudice per l’omologazione (in senso contrario, C. 9174/2008). Nonostante si assista certamente ad un progressivo riconoscimento di un sempre più ampio margine all’autonomia privata nei rapporti familiari, si deve ritenere che gli accordi dei coniugi circa i tempi di permanenza di ciascuno con i minori, compresa la determinazione di quale genitore resti nella casa familiare con questi ultimi, non possano ritenersi vincolanti a prescindere da un controllo giudiziario (o del PM) circa la rispondenza degli stessi rispetto agli interessi superiori dei minori. Ma l’accordo dei coniugi di vivere separati e cioè di allontanarsi l’uno dall’altra è vincolante a prescindere dal controllo giudiziario? Da un lato, infatti, l’art. 160 c.c. espressamente vieta ai coniugi di derogare ai diritti e doveri nascenti dal matrimonio, tanto da poter ritenere che il patto stipulato tra di essi circa la cessazione della coabitazione debba essere considerato alla stregua di un esonero dal dovere di coabitazione, il cui rilievo altro non sia se non quello di rappresentare una valida giustificazione per il coniuge che abbia lasciato la casa coniugale, con ciò escludendo la pronuncia di addebito a suo carico. D’altro canto, nelle ipotesi in cui si sia verificata l’effettiva cessazione di quella comunione materiale e spirituale che costituisce l’essenza del matrimonio e tale volontà sia comune ad entrambi, in quanto tacitamente o espressamente manifestata, la separazione procederebbe dal solo consenso dei coniugi, rilevando l’omologazione quale mera condizione legale di efficacia (C. 10932/2008), con l’ulteriore conseguenza che il consenso non potrebbe ritenersi unilateralmente revocabile (in senso contrario, tuttavia, C. App. Reggio Calabria 2.3.2006). Una volta ammesso che l’accordo circa la cessazione della convivenza produca l’effetto di rendere non revocabile unilateralmente lo stesso, si dovrebbe giungere alla conclusione che uno dei coniugi non possa costringere l’altro a ripristinare la stessa e, dunque, pur nella situazione emergenziale attuale non sia obbligato a “riprendersi in casa” l’altro. Ferma, pur sempre, l’impossibilità di ritenere coercibile l’accordo e fermo che, anche consentendo la ripresa della coabitazione, non per ciò si potrà dire accertata la riconciliazione, la quale non può ritenersi ripristinata “per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali” (C. 20323/2019).
SEDE
Via Ospedale Vecchio 29
25032 Chiari (BS)
RECAPITI
ORARI DI LAVORO
- Lun - Ven
- - -
- Sabato
- -
- Domenica
- Chiuso